
In questo Avvento riprendiamo contatto con gli ambienti che frequentia mo per la preghiera, riconoscendone il senso e il rimando liturgico che essi ci affidano. Guarderemo con semplicità ai luoghi primari (altare, ambone, cattedra) e secondari (battistero e tabernacolo). Lo scopo è rileggere gli spazi che abitualmente frequentiamo ma con uno sguardo diverso, comprendendo il senso della loro architettura e il rimando più profondo alla teologia pastorale che li accompagna.
L’Ambone
Da un punto di vista etimologico, la più comune fra le possibili origini del termine “ambone” risiede nel verbo greco anabaino (= salire). In tal senso, l’ambone farebbe riferimento a una postazione elevata verso la quale si sale per proclamare un annuncio importante. Il sostrato antropologico richiama, quindi, un luogo alto dal quale si pronunciano non parole comuni, ma proclami che posseggono rilevanza e significato particolari sia per chi li annuncia che per chi li ascolta.

Nella prospettiva iconologica, l’ambone è il luogo della proclamazione della parola di Dio e, in particolare, dell’annuncio della risurrezione di Cristo. L’introduzione al messale romano dice: L’importanza della parola di Dio esige che vi sia nella chiesa un luogo adatto dal quale essa venga annunciata, e verso il quale, durante la Liturgia della Parola, spontaneamente si rivolga l’attenzione dei fedeli. Conviene che tale luogo generalmente sia un ambone fisso e non un semplice leggio mobile (OGMR, 309).
L’iconologia dell’ambone si precisa a partire dalla teologia della parola di Dio proclamata nella celebrazione liturgica. Tale proclamazione non si riduce al racconto di un fatto avvenuto nel passato, ma è l’annuncio di una parola viva che si attua nel presente, che si fa evento nell’oggi della celebrazione, così che la voce di Dio/Cristo risuona nel suo popolo per mezzo della voce del diacono e del lettore. Non a caso al termine delle letture bibliche si declama: «Parola di Dio» e «Parola del Signore».
L’ambone, non può essere un semplice leggio, seppure di nobile fattura, o una mera postazione da cui poter facilmente comunicare. La sua collocazione non è necessariamente nel presbiterio. La rilevanza pasquale dell’ambone è indicata dalla presenza del candelabro per il cero pasquale, simbolo della luce del Signore risorto.
A proposito dell’ambone, è necessario parlare anche del pulpito: questi due elementi architettonici sono apparentemente simili e spesso interscambiati, ma posseggono connotazioni decisamente diverse. Volendo schematizzare, possiamo dire che dalla fine del primo millennio sino alla riforma del Concilio Vaticano II la proclamazione della parola di Dio nella liturgia ha perso l’importanza che le spettava, e ciò per varie ragioni di ordine storico, teologico e contingente che tralascio di spiegare, per esigenze di tempo. Di conseguenza, anche l’ambone non ha più rivestito l’importanza e il ruolo che prima possedeva. Il pulpito e l’ambone quindi non sono da confondere, poiché hanno origini e funzioni differenti.
don Flavio









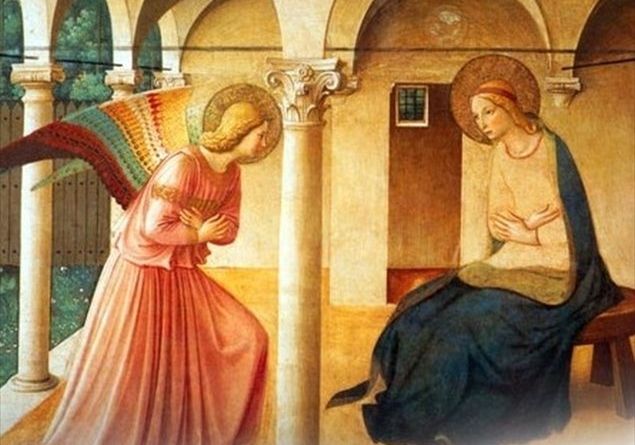






Devi effettuare l'accesso per postare un commento.